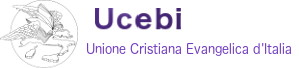Pubblichiamo il testo del sermone del culto di apertura della 46a Assemblea Generale Ucebi.
Pomezia, 22 aprile 2022 -
Non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno (Luca 12,32)
Cari fratelli care sorelle, cari amici e care amiche,
benvenuti e benvenute a questa 46ª Assemblea dell’UCEBI. La Pace del Signore sia con tutti e tutte voi.
Nel secolo scorso, conosciuto come il “Secolo breve”, c’è stata una generazione che ha vissuto la tragedia della Prima Guerra Mondiale e subito dopo quella della pandemia, nota con il nome di “influenza spagnola”, che causò la morte di oltre 50 milioni di persone. Il numero è impressionante anche perché, da sola, la Prima Guerra Mondiale aveva causato la metà delle vittime. È un fatto che quell’esperienza lasciò una profonda impressione nelle coscienze di coloro che erano rimasti, tant’è che, successivamente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, anche in letteratura, la sua eco è stata romanzata per avvicinarsi al dolore umano senza snaturarlo e violentarlo. In letteratura, è noto un brano che descrive molto bene il contesto in cui si svolgeva il vissuto di una cittadina a seguito della pandemia e che qui desidero condividere con voi.
“Il giorno in cui la cifra dei morti toccò la trentina, Bernard Rieux guardava il dispaccio ufficiale che il prefetto gli aveva passato, dicendo: “Hanno avuto paura”. Il dispaccio recava: “Si dichiari lo stato di peste. La città sia chiusa”. … Da questo momento in poi, si può dire che la peste fu cosa nostra, di tutti. …. Una volta chiuse le porte, si accorsero di essere tutti presi nel medesimo sacco e che bisognava cavarsela. In tal modo, ad esempio, un sentimento sì individuale come la separazione da una persona cara diventò subito, sin dalle prime settimane, lo stesso di tutto un popolo e, insieme con la paura, la principale sofferenza di quel lungo periodo d’esilio. …. Anche la piccola soddisfazione di scrivere ci fu negata. D’altronde, la città non era più collegata con il resto del paese … e, inoltre, un nuovo decreto vietò lo scambio d’ogni corrispondenza, per evitare che le lettere potessero diventare veicoli del contagio.”
Così Albert Camus descriveva nel suo romanzo “La peste” gli effetti inesorabili di un’epidemia scoppiata negli anni ‘40 del secolo scorso in una città algerina, Orano, che diventa teatro di una umanità che vive fra disgregazione e solidarietà e dove l’indifferenza, il panico e l’egoismo diventano i principali alleati del morbo che continua a seminare morte e a spegnere il lumicino delle flebili speranze. Ma arriva anche per la città di Orano il tempo della somministrazione di un nuovo siero, capace di estinguere i contagi. Arriva la guarigione. Le porte della città si riaprono. Il seme della speranza ridà vita alle persone e al popolo. Ma tutto questo non è gradito a chi, per tutto il tempo dell’epidemia, ha lucrato sulle sofferenze altrui: rimane deluso dalla fine della situazione a lui vantaggiosa, cade vittima di un raptus di follia e, da una finestra della propria abitazione, dà luogo a una sparatoria sulla folla, prima di essere arrestato.
Quanta somiglianza nel racconto di Camus con la situazione della pandemia da Covid-19 che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo: paura, isolamento, smarrimento, separazione, morte, malattia, dolore, guarigione. Tutti eventi sperimentati in questi due anni nel nostro Paese e nel mondo, nelle nostre vite e in quella delle chiese. Ma, anche qualche differenza significativa:
1. La corrispondenza cartacea è stata sostituita dalla comunicazione on line messa a disposizione da internet che ha posto le fondamenta per nuove modalità nel relazionarsi con gli altri, non solo nello spazio, ma anche nel tempo, a partire dalla piazza digitale in cui, purtroppo, il rischio di messaggi d’odio e di notizie false spesso contamina le coscienze e con esse le libertà e i diritti di tutti e di tutte. Ma la piazza digitale rappresenta, anche per le chiese, una grande opportunità per proclamare l’Evangelo, il regno di Dio, qui ed ora. Opportunità ben sfruttata da diverse chiese locali i cui confini costitutivi e territoriali si sono allargati, coinvolgendo persone bisognose di ascolto che non sarebbero entrate facilmente nei locali di culto.
2. Gli spari sulla folla di Orano sono stati sostituiti, dal 24 febbraio scorso, dalla guerra di aggressione dell’Ucraina, tutt’ora in corso, e che espone seriamente il mondo intero alla minaccia della Terza Guerra Mondiale. La guerra definitiva, quella nucleare.
La pandemia ci ha posto di fronte ai gravissimi effetti del regime di separazione dei popoli, degli Stati, delle Nazioni, degli Imperi, in cui ciascuna autorità nel tempo prepara, finanziando il potenziamento degli armamenti, la guerra contro l’altro, contro un nemico da individuare per poi distruggere, eliminare. Regime di separazione di mega interessi contrapposti. Da una parte, gli interessi dei Paesi ricchi che possono permettersi campagne di vaccinazione su larga scala e, dall’altra, i Paesi poveri con le loro gravissime condizioni di vita, dove, ad esempio, l’Africa avrebbe bisogno di 1,3 miliardi di dollari per pagare i costi delle operazioni di distribuzione e il personale sanitario che deve vaccinare la popolazione.
Durante questi due anni di pandemia , tuttavia, è cresciuta “la consapevolezza che nessuno poteva salvarsi da solo e che la salvezza poteva essere solo un’esperienza collettiva in cui la libertà ha preso le forme della solidarietà, privilegiando l’inclusione alla esclusione” . È stata questa consapevolezza che ha contribuito a pensare che il dopo pandemia sarebbe stato un nuovo tempo in cui tutto non sarebbe stato come prima. Un nuovo tempo in cui le distanze si potrebbero colmare abitandole con i frutti dello Spirito, realizzando un “sogno possibile” in cui all’ingiustizia subentra la giustizia, alla menzogna la verità, all’egoismo la solidarietà, all’odio l’amore, alla violenza l’ascolto, alle guerre la pace.
Con la guerra di aggressione dell’Ucraina, il secolo breve, il ‘900, come un avvoltoio, sprigiona la sua ombra mortale nel XXI secolo e infrange il tabù della pace europea. Le domande a che servono le forze armate, contro chi, con chi, hanno già trovato una risposta nella corsa agli armamenti che in qualche caso rappresenta un vero e proprio riarmo della Nazione. È interessante, a questo proposito, quanto riporta la rivista Limes: “Nel mondo che cambia, cambieremo anche noi. Da stabilire se solo da fuori, per crisi, guerre e spinte altrui, o anche da dentro, per iniziativa nostra. Con la vecchia pace, finisce l’inerzia dello status quo. Ma come quando svegliati di soprassalto ci volgiamo dall’altra parte per gustare il sonno e i sogni residui, così, se il metronomo della storia impazzisce, primo riflesso nostrano è protestare in nome dell’umanità e accucciarci in attesa di ordini che non verranno. Ha da passare la nottata. Passerà anche questa, sicuro, ma il colore dell’alba dipenderà molto da noi.”
Chiediamoci se questo pensiero geopolitico, che suona quasi come una ineludibile profezia, possa riguardare anche le chiese, cattolica, ortodossa e protestante? Chiediamoci perché, nel mondo che cambia, anche le chiese cambiano a tal punto da eludere anche la preghiera sacerdotale di Gesù al Padre e l’esortazione paolinica a “sforzarsi di conservare l’unità dello Spirito” (Efesini 4,3). Di fronte a questa triste e minacciosa realtà mondana, risuonano allora forti le domande alle chiese sul che fare e sul come affrontare le sfide che la pandemia e la guerra sollevano alla vocazione delle chiese e dei credenti, alla loro vita comune e alla loro consacrazione.
Camus, riferendosi alla strage procurata dalla pandemia, sintetizza la risposta al che fare con queste parole messe in bocca a Padre Pamelòux: “Fratelli miei, bisogna essere colui che resta!” … Bisogna mettersi in ginocchio e abbandonare ogni cosa. Bisognava soltanto cominciare a camminare in avanti nelle tenebre, un po’ alla cieca, e tentare di fare il bene.”
Questa postura del cominciare a camminare nelle tenebre ci ricorda quella del Salmista: Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me (Salmo 23,4). Secondo Jurgen Moltmann, “la pandemia è come la “valle oscura” del Salmo 23: nessuno domina la pandemia con lo sguardo, nessuno sa quanto durerà, nessuno sa quando né a chi toccherà. Dio non risparmia a noi uomini la “valle oscura”, che per molti diventa anche la “valle della morte”. Ciononostante, Dio è presso di noi nelle nostre angosce e nelle nostre sofferenze. Dio cammina con noi nell’oscurità. Non risparmia nemmeno a se stesso la “valle oscura” e la “valle della morte”. Dio attraversa i nostri stessi dolori con noi e conosce la via per noi. La fiducia in Dio sostiene la fiducia in sé, quando quest’ultima è intaccata da angosce e dolori”.
Quando le angosce e i dolori si fanno strada in noi, ci potremmo trovare di fronte a un bivio: seguire il Signore o abbandonarlo? Allora, le stesse parole di Gesù possono non trovare ascolto in noi, anche se sappiamo che sono parole di vita, le vere ed uniche parole di vita: Non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno (Luca 12,32). Questo versetto di Luca, infatti, si situa nel contesto dell’ingiunzione di Gesù ai discepoli contro le preoccupazioni ansiose che nascondono una profonda sfiducia verso Dio e verso il suo Regno . Più siamo preoccupati, più aumenta la nostra paura e la nostra ansia di perdere le nostre ricchezze a garanzia del nostro futuro, più in tal modo sfiduciamo Dio e il suo regno. Per Luca, infatti, “fede e ricchezze appartengono allo stesso ambito esistenziale. Ricchezza per Luca è Mammona. Una potenza che domina come un padrone se non è dominata. Tale ricchezza contrasta la signoria di Dio e, di conseguenza, contrasta la sollecitudine e la solidarietà con i poveri, raccomandate dalle Scritture e da Gesù.” Così la parola di Gesù: Non temere piccolo gregge riveste per noi piccole chiese, soprattutto oggi, un significato prezioso, fortemente ancorato all’azione creatrice e redentrice di Dio nella storia. Come per Israele, il suo piccolo gregge è prezioso ai suoi occhi. Egli lo stima e lo ama (Isaia 43,4). In queste parole di Gesù, comprendiamo la rassicurante promessa di Dio: Non temere io sarò con te (Isaia 43,2). E, ascoltando la voce del buon Pastore che ci conosce e ci chiama per nome una ad una, uno ad uno, siamo chiamati a seguirlo (Giovanni 10,27) senza timore alcuno.
Perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. A lui solo, e non ad altri, è piaciuto darci gratuitamente il Suo Regno. Nessun re umano ha mai donato il suo regno ai suoi sudditi. Il Regno di Dio è un regno che non ha nulla da spartire con i regni umani né con gli imperi, né con le democrazie o le dittature di oggi. Ma ciò non vuol dire che è un regno fuori dal mondo. È un regno che, pur non essendo del mondo, è nel mondo. È vicino; è scritto da Dio nei nostri cuori; è nascosto da Dio, come lo è il tesoro nel terreno o il lievito nella pasta. Dobbiamo solo cercarlo nella vita quotidiana, nelle relazioni con il prossimo: Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6,33).
Ora, Dio, prima di affidare un compito, una missione, si fa conoscere attraverso il Figlio Gesù Cristo come nostro Padre. È in questa relazione che diventiamo suoi figli e sue figlie, suo piccolo gregge. Ed è in questa relazione che fondiamo la vocazione delle chiese chiamate a proclamare nelle tenebre l’Evangelo del Regno di Dio nel tempo del silenzio di Dio e della sua assenza. La chiesa che annuncia l’Evangelo del regno di Dio assume tale compito con coraggio, tenendo bene impresse nel cuore e nella mente le parole di Gesù ai suoi discepoli: “Nel mondo avrete tribolazioni; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16, 33b) e sapendo che l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Romani 1,16).
(poiché camminiamo per fede e non per visione) (II Corinzi,7)
Come un piccolo gregge, percepiamo l’intensità dell’amore di Dio per noi, la sua potenza e la sua fedeltà conoscendo Gesù Cristo. Sapendo ch’Egli è la realtà di Dio. Di più, sapendo che Gesù è Dio con noi. L’Emmanuele, il Principe della pace. Il sentiero entro cui camminiamo per fede ha bisogno di essere illuminato ed è Gesù Cristo, morto e risorto, la luce che splende nelle tenebre nonostante la pandemia e nonostante la guerra. È lui che illumina il nostro cammino di fede (Salmo 119,105). Ed è la stessa luce su cui però possiamo inciampare e cadere. E perché possiamo inciampare e cadere? Perché ci lasciamo vincere dalla tentazione affidandoci alle cose che vediamo. Piuttosto che camminare per fede, ci esponiamo a vedere la realtà con gli occhi dei potenti, dei ricchi, dei violenti; ci affidiamo alla sapienza umana e a pensare non secondo la mente di Dio, ma secondo la mente dei principati e delle ideologie, politiche ed economiche, di questo mondo malvagio. È Lui con il suo Spirito che cammina con noi! Camminare per fede vuol dire credere che “le promesse di Dio saranno un giorno realizzate; la fede è la realtà di quelle promesse, che avanzano come un’avanguardia in azione dietro alle linee del nemico. La fede è vissuta come un’intima certezza di cose che si sperano, ma anche come la manifestazione esteriore, nel vecchio mondo, della presenza rivoluzionaria del regno di Dio che viene. La fede come realtà interiore canta: “Noi trionferemo un dì”; come realtà esteriore partecipa alle marce di Selma. La fede interiore confida nella promessa che non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore” (Apocalisse 21,4). La fede esteriore prega coraggiosamente per chi è nel lutto e presta tenera attenzione a chi piange, operando senza posa per alleggerire il dolore dei feriti. La fede interiore muove i cuori; quella esteriore muove le montagne” . Voglia il Signore guidarci nel sentiero della fede affinché non la nostra volontà ma la sua sia fatta in terra com’è fatta nel cielo e liberarci dalle tentazioni del male. Amen