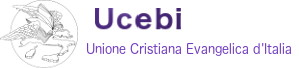Chi siamo
a cura di Domenico Tomasetto, pastore emeritoI Battisti, o più precisamente, le Chiese battiste, sono una confessione cristiana che emerge agli inizi del Seicento in Inghilterra, dal fermento inaugurato dalla Riforma protestante. Questo sconvolgimento teologico e storico aveva prodotto in Europa tre grandi famiglie confessionali: i luterani, gli anglicani e i calvinisti (“riformati” nel mondo francofono o “presbiteriani” nel mondo anglofono). In Inghilterra era stata mantenuta la chiesa di Stato (anglicana), e vi si era insediata anche una minoranza agguerrita di presbiteriani. All’interno di questi si sviluppò nel tempo un’ala molto rigida, che prese il nome di “puritani”. L’idea di chiesa prevalente in questi circoli era quella di natura nazionale, di cui le singole comunità sono parti. Fra questi puritani maturò una prima consapevolezza: la chiesa è innanzi tutto la comunità locale, la singola congregazione (da qui il nome “Congregazionalisti”), che si muove in sintonia con le altre chiese sorelle. Si sviluppò anche una seconda consapevolezza: la Chiesa deve essere separata dalla Chiesa anglicana, che è una Chiesa di Stato, quindi “asservita” alla corona (da qui il nome di separatisti).
In questo fermento maturò anche un’ulteriore consapevolezza, sempre sollecitata e guidata dalla lettura biblica: non solo la centralità della congregazione locale, ma anche la sua autonomia. La singola chiesa locale era l’elemento ecclesiologico costitutivo, il dato di base. Il libero collegamento di varie chiese locali dava luogo ad un’Unione di chiese, non ad una Chiesa “nazionale”. Inoltre, la chiesa doveva essere formata da persone rigenerate dallo Spirito del Signore e consapevoli delle loro responsabilità nei confronti del Signore e della società. Da queste considerazione si sviluppa la riflessione che questo è possibile soltanto con il battesimo dei credenti (cioè di persone che confessano personalmente la propria fede e lo fanno con il battesimo per immersione, ritenuto l’unico corrispondente alle indicazioni del Nuovo Testamento). Quindi la riflessione sulla chiesa ha portato alla riscoperta del battesimo cristiano per immersione, come testimoniato nel Nuovo Testamento.
Perché questo potesse avvenire era necessario un ulteriore passo: in una società in cui tutti i bambini erano battezzati appena nati, si poneva il problema dell’appartenenza (decisa da altri!) ad una chiesa. In paesi con religione di Stato, c’era un’identificazione molto rigida e “automatica” fra cittadini e membri di chiesa, con il risultato d’avere chiese territoriali, di massa, senza altra alternativa. Per rispondere a quest’esigenza i battisti rivendicarono la libertà di coscienza e la affermarono come uno dei loro principi distintivi. Erano nate le chiese battiste.
Questa nuova formazione ecclesiastica, pur mantenendo e riaffermando i grandi principi teologici della Riforma protestante, si contraddistingue dalle altre chiese “evangeliche” (questo è il nome collettivo che esse si davano, mentre “protestante” fu un nome dato dagli avversari con intento denigratorio, ma che ormai è entrato nell’uso) per alcuni principi di base, unici a quel momento:
- la concezione della chiesa;
- il battesimo dei credenti per immersione;
- la libertà di coscienza;
- la completa separazione fra Chiesa e Stato.
Altre Chiese evangeliche, sorte in seguito, hanno ripreso questi principi e modificato alcuni aspetti teologici dell’eredità della Riforma protestante. Oggi, quindi, questi principi sono vissuti da molte chiese evangeliche, che ne condividono la portata e il significato. Costituiscono un patrimonio ideale e teologico comune.
Quali sono i nodi che questi principi hanno cercato di sciogliere? Li esaminiamo brevemente.
1. La concezione della chiesa (tecnicamente: ecclesiologia) che i battisti hanno elaborato vede la singola comunità locale come dato fondamentale e irrinunciabile d’ogni discorso ecclesiologico. Ogni comunità locale è autonoma nel suo essere ed operare e liberamente si unisce con altre chiese consorelle a costituire Associazioni di zona e Unioni nazionali. Queste non sono dati che fondano la natura della chiesa, dimensioni della chiesa, ma strutture ecclesiastiche, spesso di tipo territoriale o “amministrativo”. I responsabili nominati nelle rispettive assemblee hanno carattere amministrativo e rappresentativo, non religioso. Ogni chiesa locale è autonoma e si autogoverna: del suo operato risponde responsabilmente soltanto al Signore e a se stessa, nel corso delle sue assemblee. Il fatto d’essere chiesa non deriva dal riconoscimento ufficiale di un terzo (sia esso un’autorità religiosa o statale), ma dalla propria consapevolezza dinanzi al Signore e alle altre chiese cristiane. Di solito questo avviene mediante la formulazione di una Confessione di fede, in cui sono enunciati i dati teologici che ne permettono l’identificazione. La chiesa è costituita da credenti confessanti e responsabili dinanzi al Signore e ai loro confratelli e consorelle.
2. Il battesimo per immersione dei credenti prevede che il battesimo avvenga in una forma specifica (per immersione totale del battezzato in acqua) e che il credente sia in grado di confessare responsabilmente e personalmente la sua fede (parlare di battesimo degli adulti è una semplificazione imprecisa). Lo schema teologico sotteso a questa concezione è che ogni persona, all’ascolto dell’annunzio dell’evangelo, vi dia la propria adesione in seguito alla conversione. Con il battesimo per immersione, il credente diventa parte del Corpo di Cristo, della chiesa locale. Questo è lo schema teologico e la prassi battesimale che si ricava direttamente dal Nuovo Testamento. Tutte le chiese cristiane che hanno questa prassi rivolgono una domanda alle chiese consorelle che praticano il battesimo dei fanciulli sulla legittimità e sul fondamento biblico-teologico della loro prassi battesimale.
3. La libertà di coscienza è diventato oggi un diritto inalienabile d’ogni persona. Assieme all’altro principio più generale della libertà religiosa, oggi caratterizzano il modo di pensare del mondo moderno. Il dato fondamentale che questo principio mette in evidenza è quello della libertà di agire in base alle proprie convinzioni più profonde. Questo principio trova la sua applicazione primaria in problematiche religiose, dove appunto è stato sollevato per la prima volta. Il dato che si vuole salvaguardare e riconoscere è se una persona ha o no il diritto di agire in base alle proprie convinzioni o se deve accettare supinamente le scelte altrui o agire in base a costrizioni esterne di vario genere. I battisti hanno rivendicato questo principio che permette ad ogni credente di aver parte nella chiesa che sente più vicina ai suoi convincimenti più profondi, sia per avvicinarsi al mondo battista, sia per avvicinare altre chiese e movimenti religiosi.
4. La separazione fra Chiesa e Stato è un altro dei principi che i battisti hanno rivendicato e che oggi si pone alla base di qualsiasi Stato laico. Prima di allora vigeva o il cesaropapismo (la chiesa prevaleva sullo Stato e ne determinava le leggi), oppure il giurisdizionalismo (lo Stato dettava le leggi per materie riguardanti l’ambito ecclesiastico). I battisti hanno ritenuto che le due realtà avessero ciascuna il proprio ambito di competenza e che nessuna dovesse prevalere sull’altra, che ci fosse una separazione netta dei due ambiti. Per questo sono conosciute di solito come “Chiese libere”. Per le materie di comune interesse, Stato e Chiesa devono trovare una soluzione equilibrata che tenga conto delle rispettive competenze, ma senza alcun’ingerenza reciproca. Nel tempo questo è diventato il principio base della laicità dello Stato, che garantisce a tutte le manifestazioni religiose di potersi esprimere e organizzare liberamente, fatto salvo il principio del rispetto dell’ordinamento statale.
In conclusione: i battisti, che hanno le loro radici nella tradizione teologica della Riforma protestante del XVI secolo, e più direttamente nell’ala calvinista, hanno rivendicato posizioni specifiche e originali sia per quanto riguarda la concezione della chiesa e il battesimo dei credenti, sia per quanto riguarda il rapporto fra chiesa e Stato, battendosi in modo significativo per i principi della libertà di coscienza, della libertà religiosa e della separazione fra Chiesa e Stato, contribuendo così all’affermazione della laicità della Stato. Libere chiese in libero Stato.